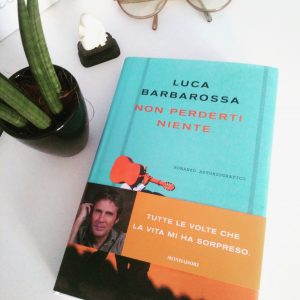E’ uscito recentemente per la casa editrice Mimesis il volume La via mistica di George Harrison. Musica, Maya, Risveglio. Un libro originale e innovativo, in cui musica e filosofia si fondono, accompagnando l’autore (e il lettore) in un viaggio alla scoperta di sé, attraverso il percorso creativo del Beatle più mistico di tutti.
Un volume per provare a riscoprire le canzoni di Harrison attraverso una nuova luce, con riferimenti ad Hesse, Schopenhauer, Yogananda, per un ascolto più consapevole e profondo. L’autore, Alberto Rezzi, ci racconta la nascita della sua fatica letteraria.
Lei racconta il suo approccio con Harrison come una sorta di incontro con una guida spirituale. Come è iniziato questo viaggio?
È un viaggio iniziato da un ascolto più attento delle canzoni di Harrison, soprattutto quelle da solista. Mi sono reso conto di non averle mai davvero ascoltate, e che per cercare di coglierne a fondo l’essenza dovevo approfondire la conoscenza di quel terreno spirituale e filosofico in cui erano nate e da cui avevano preso vita. Ascoltando le sue interviste e leggendo la sua “autobiografia”, mi sono imbattuto in un artista che ha davvero fatto propria la visione del mondo indiana e che per tutta la vita ha cercato di vivere secondo questa ispirazione. Un tentativo tanto affascinante quanto complesso, trattandosi di uno dei musicisti più noti al mondo e per sempre segnato dall’esperienza Beatles. Ma è proprio questo che me lo ha fatto amare e sentire particolarmente vicino: il tentativo di tenere vivo il “fuoco spirituale” continuando a vivere nel mondo materiale, per citare un suo noto album. In questo senso nel libro parlo del mio “incontro” con lui alla stregua del discepolo che, smanioso di conoscere e mettersi alla prova, cerca una guida vera, un dissipatore delle tenebre… E non ho remore a dire che è stato un incontro che mi ha trasformato.
Quanto ha influito la sua formazione filosofica nell’approccio alla musica di Harrison?
La magia dell’arte e delle canzoni in particolare è la capacità di veicolare idee, intuizioni, pensieri in forma immediatamente accessibile, e in questo Harrison è stato indubbiamente un maestro. In qualche modo mi viene naturale collegare alcuni versi a precise visioni filosofiche, scoprirne la consonanza e indagarla. In questo caso, ad esempio, ho ripreso un filosofo controverso come Arthur Schopenhauer, spesso frettolosamente bollato come pessimista e presto archiviato, per sondare alcune canzoni harrisoniane che fanno riferimento al tema – così caro al pensiero indiano – del velo dell’illusione, di Maya, dell’inganno in cui tutti noi più o meno consapevolmente conduciamo le nostre esistenze. Ma anche per approfondire temi non sempre così esplorati nella musica pop, come il mito della trasmigrazione dell’anima e l’“arte del morire”, per riprendere un altro meraviglioso brano di George. Insomma, mettere in dialogo musica e filosofia è un esperimento appassionante, che coltivo da anni, cercando di creare ponti tra due linguaggi certamente diversi, ma in grado di allargare i nostri orizzonti conoscitivi, esperienziali ed emozionali.

E’ difficile per l’uomo occidentale comprendere davvero a fondo la cultura e le teorie filosofiche orientali?
Per un verso sarei portato a rispondere che non è facile avvicinarsi realmente a questo sistema di pensiero, che sotto molti aspetti muove da premesse molto diverse e distanti dalle nostre. D’altro canto, però, credo che sia utile porre al centro la continua ricerca di risposte e di pace dell’essere umano. In questa prospettiva, una sapienza millenaria come quella indiana, l’immenso patrimonio di intuizioni dei primissimi rishi e mistici, può offrire nuovi punti di vista sulle questioni che da sempre ci riguardano, ma che spesso cerchiamo di risolvere con risposte a buon mercato o facendo come se non ci interpellassero direttamente. La cosa sorprendente è poi scoprire come alcune visioni trovino eco e assonanza con alcuni fondamenti del nostro pensiero, come ad esempio Platone. Si tratta, quindi, di elaborare una propria sintesi, arricchita dal confronto con una cultura diversa dalla nostra ma al contempo universale.
Un breve aneddoto riguardante lo stesso Harrison può essere illuminante in questo senso: dopo essersi immerso nell’approfondimento e nell’assimilazione della filosofia indiana, il suo “maestro” e amico Ravi Shankar, il grande sitarista e compositore, lo esortò a riflettere profondamente sulle sue radici: anzitutto musicali, ma anche culturali in senso ampio. Un invito che colse di sorpresa lo stesso George, il quale solo dopo un certo percorso arrivò a comprendere che, nonostante l’immenso fascino esercitato dal sitar e dalla musica indiana, il suo “campo da gioco”, per così dire, era la musica pop occidentale. Senza questo “ritorno” probabilmente non avremmo avuto le sue meravigliose composizioni dell’ultimo periodo beatlesiano né la sua produzione da solista, che raggiunge la maggior originalità proprio cucendo elementi della spiritualità indiana, sonorità orientali e melodie occidentali.
Anche oggi c’è un avvicinamento all’Oriente, fra meditazione e pratiche yoga. E’ diverso il nostro approccio rispetto a quello degli anni Settanta?
Lo è inevitabilmente, perché allora faceva parte di un movimento culturale più ampio che portava con sé anticonformismo, desiderio di rivoluzionare il costume e la cultura dell’epoca, scontro generazionale ecc. Oggi credo sia un fenomeno più votato al “benessere” individuale, il che è buono e legittimo, ma spesso viene portato avanti in modo parcellizzato, come molte cose nella nostra società. Spesso si prendono e si eseguono posizioni yoga o tecniche meditative disancorandole da un percorso spirituale più ampio e trasformativo, da un’autentica ricerca di trascendenza, da un orizzonte sapienziale che cerchi di superare gli stretti vincoli del nostro Io individuale. Nondimeno, grazie a questa abbondante offerta c’è più possibilità rispetto al passato di avvicinarsi a conoscenze e visioni del mondo diverse dalla nostra.
Quanto è stato determinante per Harrison l’incontro con Ravi Shankar?
Come lui stesso ha sempre ricordato, è stato decisivo perché gli ha permesso di entrare in contatto diretto con la musica e la filosofia indiane, di focalizzare le proprie ricerche e di trovare immediate risposte alle sue domande e curiosità. Ravi è stato in questo senso un maestro e un “ponte” indispensabile per George, ma è stato anche molto altro. Un amico fraterno, un compagno di viaggio e di divertimento, un confidente sincero, oltre che la testimonianza vivente di un’esistenza votata all’arte e alla ricerca del costante perfezionamento di sé. Durante la stesura del libro mi sono immerso nell’ascolto di un album come Chants of India, uscito nel 1997, curato da Ravi e prodotto da George. È emblematico del loro rapporto di amicizia e di collaborazione artistica, perché si basa su una sensibilità comune e un preciso intendimento: far conoscere la musica indiana a quante più persone possibili, consapevoli di quanto possa essere benefica e confortante nelle esistenze di ciascuno. In fondo, è lo stesso intendimento che i due intrapresero decenni prima, poco dopo essersi conosciuti a metà anni Sessanta.
Qual è la canzone dei Beatles più “harrisoniana” e quella di Harrison post Beatles più “beatlesiana”?
Personalmente sono molto legato ad I Me Mine, sia come brano in sé (nonché titolo della sua “autobiografia”), sia per quello di cui parla, sia perché appartiene proprio all’ultima fase dei Fab Four. È per certi versi un’istantanea di quello che stava accadendo tra di loro ma anche chiaro presagio di quello di cui George si sarebbe occupato in molte altre canzoni: la ricerca della propria identità al di là di ogni egolatria. Ci sono però altre canzoni di cui mi occupo in particolare nel libro che portano chiaramente il marchio Harrison: The Inner Light, Within You Without You, Long Long Long… Tra quelle più beatlesiane istintivamente penso a When We Was Fab, uscita nel 1987 nel decennio dell’omicidio Lennon ed emblematica della pace che George aveva iniziato a fare con quel periodo unico ma non meno controverso, soprattutto per lui.
Quanto ci ha messo Harrison ad allontanarsi dal personaggio di “Beatle George”? I Beatles nelle loro carriere solistiche sono riusciti davvero a non essere più “ex beatles”?
Indubbiamente è stato un percorso lungo e difficile, probabilmente più di quanto lo stesso Harrison avesse messo in conto. Com’è noto, finita l’esperienza Beatles, aveva accumulato moltissimo materiale inedito di enorme valore, confluito poi nel triplo album All Things Must Pass che vide la luce proprio sul finire di quel fatidico 1970. Il successo planetario di questo primo lavoro post-Beatles inaugurò una carriera solista estremamente interessante, che però lo vide progressivamente prendere le distanze dal “music business”, in particolare a seguito dell’esperienza traumatica del tour del 1974, quando toccò con mano come una certa parte di pubblico si aspettasse di riascoltare i successi di “Beatle George” e fosse meno aperta alle nuove canzoni più spirituali e intrise di misticismo indiano. Per nostra fortuna, Harrison avrebbe continuato a coltivare il suo modo originale e unico di fare musica, a scrivere delle sue ricerche e delle sue contraddizioni, a creare melodie e versi, riuscendo anche, e non da ultimo, a rivisitare l’esperienza Beatles in chiave umoristica e sarcastica insieme agli amici dei Monty Python. Questo è un tratto della sua personalità che mi ha sempre affascinato molto: usare la chiave dell’ironia per “alleggerire il peso” di determinate esperienze. Un tratto tipicamente harrisoniano, che trova riflesso in diverse sue canzoni e video musicali: penso a Crackerbox Palace, This Song o Blow Away, ad esempio. Credo che per lui in particolare aver fatto parte di quell’esperienza e aver raggiunto The Top in così giovane età lo abbia portato a interrogarsi molto seriamente e senza compromessi sul senso di quegli anni, sul suo percorso esistenziale e, di nuovo, sulla sua vera identità: umana, artistica e spirituale.